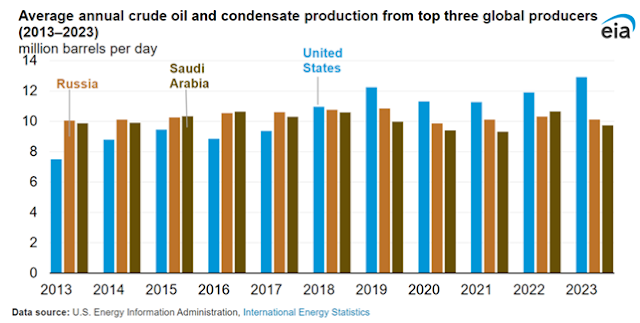INTERVISTA. Parla il poeta, scrittore e musicista israeliano. «Dopo il 7 ottobre le mie opinioni non sono cambiate, né la mia posizione sulla questione palestinese. Credo nella convivenza in uno spazio multinazionale e multireligioso »
di Olga Dalia
Padoa *
A più di sei mesi dal
7 ottobre Shimon Adaf, poeta, scrittore e musicista israeliano nato da una
famiglia di origine marocchina a Sderot, una delle città sfollate nel sud di
Israele all’inizio della guerra a Gaza, non accetta di dover «continuare a
vivere sempre in guerra», e allo stesso tempo è deluso dall’ostilità dei
partiti progressisti europei. Secondo Adaf, la criminalizzazione dello Stato
ebraico «alimenta la retorica della destra israeliana, già convinta che tutto
il mondo sia contro di noi; per non parlare della destra mondiale che spesso
usa Israele in maniera strumentale per portare avanti i propri obiettivi».
Come vive questa
situazione la sinistra israeliana, con le accuse di genocidio e gli studenti
universitari in piazza che chiedono il boicottaggio?
La sinistra israeliana
ha sempre fatto riferimento ai movimenti progressisti e liberali di tutto il
mondo, ma ora la sensazione è che ci abbiano lasciati soli: è come se ci fosse
una rimozione totale delle perdite israeliane ed esistessero solo quelle palestinesi.
Ciò ovviamente non significa che le critiche a Israele non siano legittime, ma
ignorare il fatto che la gente di qui sia stata uccisa e bruciata nelle proprie
case, non riconoscere la sofferenza degli ostaggi, delle donne violentate, mi
sembra disumano – nella stessa misura in cui sono disumane le azioni di Israele
in questa guerra.
Come giudica la
polarizzazione che si è creata nel dibattito pubblico sul conflitto in Medio
oriente?
Siamo pervasi da un pensiero dicotomico, hollywoodiano, in cui l’impero del
male conquista una minoranza mansueta e pacifica, e noi spettatori ci
identifichiamo con i guerrieri per la libertà. Ma fatta eccezione per casi
molto particolari, questo non è mai avvenuto nel corso della storia. È una
fantasia in cui l’Occidente continua a cullarsi, forse per liberarsi dei sensi
di colpa dovuti al suo passato colonialista. A mio parere la questione è invece
di tipo pratico. Se cominciamo ad andare indietro nel tempo, concentrandosi
sulla questione di chi abbia più diritti su questa terra anziché su come
trovare una soluzione, non si arriva da nessuna parte. E il prisma del
colonialismo non aiuta a capire quello che succede qui, perché è una situazione
molto più complessa: non sono le colonie francesi in Algeria, né quelle inglesi
in India. Gli ebrei che sono arrivati 60, 80 o 100 anni fa qui non sono gli
emissari di un impero immaginario, e non hanno un luogo in cui tornare.
È un tema che affronta
anche nel suo ultimo racconto, in cui parla di una famiglia sfollata di Sderot
che torna nel proprio appartamento e che si sforza di non guardare nella crepa
che si è creata con questa guerra. Solo una bambina ha il coraggio di voler
capire cosa sta succedendo. Perché?
Ho scelto il punto di vista di una bambina perché penso che nei bambini ci sia
un senso della giustizia istintivo, a volte anche selvaggio, che pretende il
rispetto delle regole, dei principi, del prossimo. Gli esuli descritti nel mio
racconto sono gli israeliani sfollati dalle proprie case ma anche i profughi di
Gaza, sono tutti coloro che sono stati colpiti da quest’inferno. Gli adulti
spesso usano molte scuse e sovrastrutture per non comportarsi in modo etico, ma
non si può dire che ci sia una giustizia per una popolazione che vive sotto
occupazione e un’altra per la popolazione occupante.
Cosa pensa delle
proteste e delle manifestazioni contro Netanyahu che si susseguono ogni
settimana?
Ironicamente, il tentativo di Netanyahu di manomettere il sistema politico e
giudiziario ci ha insegnato che non si può separare la concezione economica da
quella politica, quella securitaria da quella nazionalista: fanno parte dello
stesso continuum. Proprio durante l’anno della cosiddetta “riforma giudiziaria”
sono stato coinvolto in un progetto presso l’Istituto Vanleer di Gerusalemme
sul tema del post-capitalismo: ci siamo dati la libertà di immaginare una
società post-nazionalista e post-capitalista in Medio Oriente. Un ordine
sociale, culturale ed economico in cui il principio di cittadinanza prescinde
dall’appartenenza nazionale o religiosa. In questo momento sembrerebbe un
orizzonte utopico o addirittura messianico, ma l’immaginazione precorre sempre
la realtà, e il ruolo della letteratura e dell’arte è imprescindibile.
Gli israeliani sono
disillusi sulla possibilità di siglare una pace con la leadership palestinese?
Molti dicono di essere stati ingenui, credendo che la pace fosse possibile. Ma
se gli si chiede, «Allora cosa è possibile? Qual è la soluzione?» non trovano
una risposta. Tutta la concezione politica del centro-destra consiste nel
creare un ristagno, sostenendo che in assenza di una soluzione non si può fare
altro che tirare avanti, continuare a risolvere piccole o grandi crisi. Ed è
una sensazione è molto diffusa. Ma allora cosa facciamo, accettiamo di vivere
in guerra per sempre? Io questo non lo concepisco.
Cosa è cambiato in lei
dopo lo shock del 7 ottobre?
Le mie opinioni non
sono cambiate, così come la mia posizione riguardo alla questione palestinese.
Credo nella convivenza in uno spazio multinazionale e multireligioso. Non sono
ingenuo a riguardo. Si tratta di un processo lungo e pieno di sfide. Ciò che
invece mi ha deluso sono le teorie politiche degli ultimi decenni. Il fatto che
si traducano molto facilmente in dogmatismo omicida a destra e a sinistra
dimostra che non sono più in grado di descrivere la realtà e tanto meno di
apportarvi un miglioramento.
* da il manifesto - 29
aprile 2024